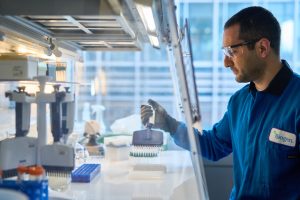Sola a prendersi cura della figlia per decenni, una madre disperata compie un gesto estremo: una storia che mette in luce il peso invisibile dei caregiver e il fallimento della società.
Il dramma della fragilità
In un paese della Sicilia, pochi giorni fa, una donna di 78 anni — rimasta sola a prendersi cura di sua figlia disabile dopo la morte del marito — uccide la figlia di 47 anni, con una grave disabilità, e subito dopo si toglie la vita.
Questa, da sempre dipendente dalla madre per ogni gesto quotidiano, viene strangolata con una corda; la mamma si impicca poco dopo nell’abitazione che condividevano.
Alla base del gesto — emerge da una lettera lasciata dalla madre — la disperazione per la fatica della cura quotidiana, la sensazione di solitudine, l’angoscia per il futuro della figlia quando lei non ci sarebbe stata più, la paura che nessuno si sarebbe occupato di lei come aveva fatto per decenni.
Quando l’amore si trasforma in peso
Una tragedia come questa costringe a interrogarsi su ciò che può scatenarsi nella mente e nel cuore di chi per anni ha fatto da braccia, da gambe, da voce a un’altra persona. Che cosa può portare una madre a porre fine alla vita di sua figlia e alla propria?
Quali emozioni, quali paure, quale disperazione maturano lentamente fino a diventare insopportabili?
Il carico invisibile della cura
Chi assiste una persona con disabilità grave vive un’esistenza in cui la cura diventa totalizzante.
Non è solo un impegno quotidiano: è un’identità.
La madre che si prende cura diventa le sue braccia, le sue gambe, la sua voce. Ogni gesto che per gli altri è scontato — mangiare, bere, vestirsi, spostarsi — è per lei responsabilità assoluta.
La sua presenza non è un aiuto: è ciò che consente alla figlia di vivere.
Paura e ossessione per il futuro di chi non può prendersi cura di sé
Con il passare degli anni la giovinezza lascia spazio alla fragilità. Il corpo si affatica, le energie si riducono, la mente si appesantisce. Ed emerge una domanda che può diventare un’ossessione: chi avrà cura di lei quando io non ci sarò più? Chi le darà da mangiare, chi le farà bere se avrà sete, chi interpreterà i suoi bisogni, chi la proteggerà dalle omissioni e dagli abbandoni del mondo? È una paura che lacera.
Una madre può sentirsi intrappolata tra l’amore assoluto per la figlia e la consapevolezza crescente che il suo tempo sta per terminare.
Ogni giorno questa consapevolezza diventa più pesante, più concreta, più spaventosa.
E se non esiste una rete, se lo Stato non sostiene, se la comunità non vede, quella paura può trasformarsi in disperazione.
Colpa, isolamento e cedimento
Dentro questa disperazione spesso si accumulano anche senso di colpa e vergogna.
La madre può percepirsi come un peso, come qualcuno che non ce la fa più, come un’anima stanca che teme di fallire.
L’isolamento aumenta.
Le giornate si ripetono identiche, senza pause né sollievo. Quando non esistono spazi di respiro e il supporto
manca, la solitudine può diventare totale.
La mente, sotto questo peso, può cedere.
In quel cedimento può maturare il gesto estremo: non come violenza, ma come una forma di protezione distorta e disperata.
Un tentativo di evitare alla figlia ciò che lei teme più di tutto: l’abbandono, l’indifferenza, l’assenza di cure. Una decisione tragica che nasce dalla convinzione che senza di me lei non può vivere.
Il fallimento della comunità e dello Stato
Ogni volta che accadono storie come queste non si tratta solo di una tragedia personale.
È un fallimento dello Stato e dell’intera comunità. È il fallimento di un sistema che lascia sole le famiglie, che scarica tutto sulle spalle di un caregiver, quasi sempre una donna.
È il fallimento di politiche che non garantiscono servizi adeguati, che non offrono sollievo, che non costruiscono un “dopo di noi” reale.
È il fallimento di una società che permette che una madre arrivi a temere più la solitudine futura di sua figlia che la propria morte.
La necessità di un impegno condiviso
Non basta provare pietà o sgomento. Bisogna chiedersi che cosa non ha funzionato, quali segnali sono stati ignorati, quali reti non sono state costruite.
La cura non può essere un atto solitario né un sacrificio totale.
Deve diventare un impegno condiviso, sostenuto, strutturato.
Quando una madre arriva a credere che l’unica protezione possibile sia la tragedia significa che come società abbiamo fallito.
C’è un’urgenza che non può essere rimandata: costruire comunità e istituzioni capaci di prendersi cura dei più fragili e di chi se ne prende cura.
Solo così l’amore tornerà a essere forza e non abisso.